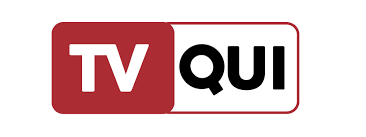Stefano Bussolari (già Commissario Polizia locale città metropolitana di Bologna)
Il Piccione selvatico occidentale (Columba livia, Gmelin 1789), o torraiolo, è la specie dalla quale discende per dinamica evolutiva anche la Columba livia forma domestica. L’odierno inquadramento del colombo o piccione di città è stato definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004, della Sezione III penale, la quale ha stabilito che il piccione di città deve essere considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.
Da questa sentenza discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città (che comprende anche i sinantropi che stazionano o transitano nelle aziende agricole) va individuato nella legge “Quadro” n. 157/’92 inerente le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria”. La quale L. 157 al comma 2 dell’art. 19 dà facoltà alle Regioni di operare il controllo della fauna selvatica:
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.
È importante il monitoraggio sanitario, dove i piccioni convivono con il bestiame per la prevenzione in particolare di patologie fungine come l’istoplasmosi che nei bovini causa problemi a carico dell’apparato respiratorio.
La Regione Emilia Romagna per recepimento ha attualmente in campo lo strumento determinato dalla Delibera di Giunta n° 241 del 2023: Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia Romagna (Columba livia forma domestica).
I danni arrecati alle produzioni agricole dal piccione accertati dalla Regione, così come prevede l’art.17 della L.R. n. 8/1994, avevano toccato i 241.000 euro nel 2021. Le colture maggiormente suscettibili di asporto sono: barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo; le colture, tra queste, destinate all’industria agraria rappresentano il 24,7% sul totale.
La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, annualmente, finanzia l’acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica mediante avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti (in questo senso raccomando di consultare il sito Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione e stare a contatto con le Organizzazioni Professionali Agricole). I metodi dissuasivi ecologici ed incruenti, il cui tentativo è obbligatorio, sono: nastri olografici riflettenti, specchietti, reti di protezione laddove vi siano pareti o strutture che lo consentano, sagome di falco, palloni predator, sistemi vocali di allontanamento (distress call), ultrasuoni, detonatori temporizzati (cannoncini a gas), dissuasori ottici, copertura con reti simil antigrandine, palloni ad elio tipo “helikite” (buona efficacia). Il consiglio e di usare più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Qualora i metodi alternativi correttamente applicati non si dimostrino efficienti, il Piano Regionale prevede anche il ricorso a piani di abbattimento mediante specifiche tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d’azione; un obbligo normativo ed etico che dobbiamo a qualsiasi specie faunistica.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 8/1994, i prelievi e gli eventuali abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l’attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all’art.19 della citata Legge n. 157/’92, di operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal Personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. La vigilanza sulle operazioni previste dal piano regionale è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia provinciale o della Polizia locale della Città metropolitana responsabili per territorio con l’eventuale supporto dei Carabinieri Forestali.
Le operazioni di prelievo sono attivate a seguito di specifica richiesta alla Polizia provinciale o Locale della C.m. che esamina l’istanza e verifica le condizioni di fattibilità subordinate alla prevenzione ed alla fattibilità in relazione al contesto.
La richiesta può essere inoltrata da parte del Proprietario o Conduttore del fondo agricolo; oppure a seguito di diretta segnalazione dei Settori Agricoltura Caccia e Pesca della Regione alla Polizia Provinciale competente per territorio con riferimento all’evoluzione dei danni evidenziatisi. I Sacp possono raccogliere indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio da parte delle Associazioni Professionali Agricole locali. I piani di controllo sono attuati dai cacciatori, che, in questo caso, assumono la figura non più di cacciatori ma di incaricati di pubblico servizio, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale. I Piani sono coordinati dagli Agenti dei Corpi di Polizia provinciale che li possono attuare anche direttamente.
Le Autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, concessione governativa, assicurazione e previa frequenza ai corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Nel caso si operino catture selettive in vivo mediante gabbie-trappole, la Delibera di Giunta n° 241 del 2023 non ravvisa la necessità che gli operatori, comunque formati dagli organi competenti e coordinati dalle Polizie provinciali, dispongano della licenza di caccia poiché le tecniche di soppressione previste dopo la cattura non rendono necessario il suo possesso. I suddetti operatori dovranno agire sempre nel rispetto dei precetti del suddetto Piano Regionale.
Un po’ di dati su questa specie
La specie originariamente stanziata in ambienti rupestri di elezione per sopravvivere ha progressivamente cercato nel corso dei secoli la vicinanza mutualistica con l’uomo, in prossimità del quale rinveniva alimenti e semi. Gli agricoltori a loro volta traevano alimento dal columbide conservandone comunque gli indici di abbondanza. Divenendo così piccione domesticato si sono poi ottenute una varietà di razze con molteplici tratti e colori e oltre dieci sottospecie riconosciute. Il Columba livia forma domestica include, infatti, i “viaggiatori” e numerose razze da cui discendono i colombi semi-selvatici diffusi in quasi tutta Europa, soprattutto nelle zone rurali ma anche inurbate.
Nella “Grande Guerra” i piccioni arruolati nelle “trasmissioni” furono circa 200.000; Cher Ami, un piccione femmina, salvò ben 200 commilitoni durante la Prima guerra mondiale sul fronte delle Argonne, portando a destinazione il messaggio benché ferita. Il suo corpo imbalsamato è attualmente conservato ed esposto nel National Museum of American History a Washington, D.C..
Secondo Alessandro Ghigi, già rettore della Università di Bologna e lontano fondatore dell’ odierno I.S.P.R.A., le razze domestiche di piccioni possono essere raggruppate in due grandi gruppi: Homaemorphae e Heteromorphae. La prima comprende tutte le razze che per loro struttura anatomica non differiscono in modo apprezzabile dalla livia e dai selvatici in generale (es.; Fattore o piccione comune, Monadin francese a tarsi nudi e il Romagnolo a tarsi pennuti). La sezione Heteromorphae comprende invece le razze che hanno acquistato caratteri anatomici che non compaiono in alcuna specie di colombo selvatico (es.: Piacentino, Reggianino e Triganino modenese).
Rispetto al selvatico, il colombo di città si presenta più robusto e pesante (300-400 grammi, rispetto ai 220-300 grammi del selvatico), lungo circa 36 cm e con livree di piumaggio molto variabili, a segno della forte incidenza d’immissione di razze domestiche anche aufughe. Il petto è arrotondato, con capo piccolo e zampe corte. Il becco è corto e di colore nero mentre le zampe sono rosso scure, con unghie nere. Il piumaggio, comunque fitto e soffice, negli individui più simili ai progenitori è di colorazione variabile secondo le tonalità del grigio e del blu: la testa, il collo e il petto sono color ardesia, la parte inferiore del corpo è grigio-azzurra mentre il dorso è di colore grigiastro molto chiaro, con groppone biancastro che può essere assente. Nel collo e nel petto spesso si apprezzano piume iridescenti le quali formano una particolare sfumatura metallica – verde intenso, indaco e viola. Le ali, di colore cenerino molto chiaro con pagina inferiore biancastra, sono attraversate da due fasce nere, hanno penne remiganti color grafite mentre le timoniere, più chiare, hanno terminazione nera e vessillo esterno bianco. Gli occhi presentano iride arancione negli esemplari adulti, marrone in quelli giovani e sono spesso circondati da una zona di pelle nuda di colore chiaro.
La muta post riproduttiva degli adulti è completa, mentre quella post giovanile è parziale (molti individui giovani iniziano la muta delle remiganti primarie all’età di circa 50 giorni, ma generalmente viene sospesa in inverno per poi riprendere in primavera). L’età media è di 2,4 anni; i colombi che vivono in ambienti rurali possono superare i 10 anni. La maturità sessuale è raggiunta tra i 6 e gli 8 mesi. Le coppie mostrano un’elevata fedeltà al partner, così come ai siti di nidificazione, rappresentati precipuamente da buchi e altre cavità artificiali, sottotetti e sporgenze con riparo molto frequenti nei nostri immobili rurali e ricoveri bestiame. A circa 8-10 giorni dall’accoppiamento, sono deposte 2 uova ad un intervallo di 24 ore l’una dall’altra; l’incubazione inizia dal secondo uovo deposto e viene portata avanti da entrambi i partner per 18 giorni. Alla nascita i piccoli sono nidicoli, per cui inetti, ciechi e ricoperti di un rado piumino giallo. Fino al quinto giorno di vita, i piccoli sono alimentati con il cosiddetto “latte del gozzo” secreto nell’ingluvie dei genitori poi, lo spettro alimentare si amplia, includendo granaglie di vario tipo. I piccoli stanno nel nido per circa tre settimane e dopo un mese si involano. In media una coppia si riproduce 5-6 volte l’anno, anche se sono riportati casi riferiti a 9 covate annue (Murton et al., 1972). Una coppia produce in media 3-4,5 nuovi nati l’anno determinando un tasso d’incremento della popolazione pari al 150%.
Se il selvatico rupestre va considerato come il progenitore di tutte le razze domestiche, i suoi prodotti sono con queste interfecondi tra loro e con entrambe le razze, alle quali appartengono i genitori. L’ampia variabilità morfologica dei colombi urbani o sinantropi rurali (difforme livrea del piumaggio, tarsi piumati, ecc.), superiore a quella di qualsiasi popolazione naturale, testimonia l’origine da diversi gruppi allevati. La presenza di caratteri cromatici recessivi è indice di fenomeni d’ibridazione anche recenti sia con soggetti urbani, sia con selvatici. Questa apoteosi dell’ibridazione ha determinato per tutto il ‘900 un singolare “limbo” normativo che ha portato a considerare i piccioni non allevati, o come “proprietà della collettività o del Comune”, o “cosa di nessuno (res nullius)”.